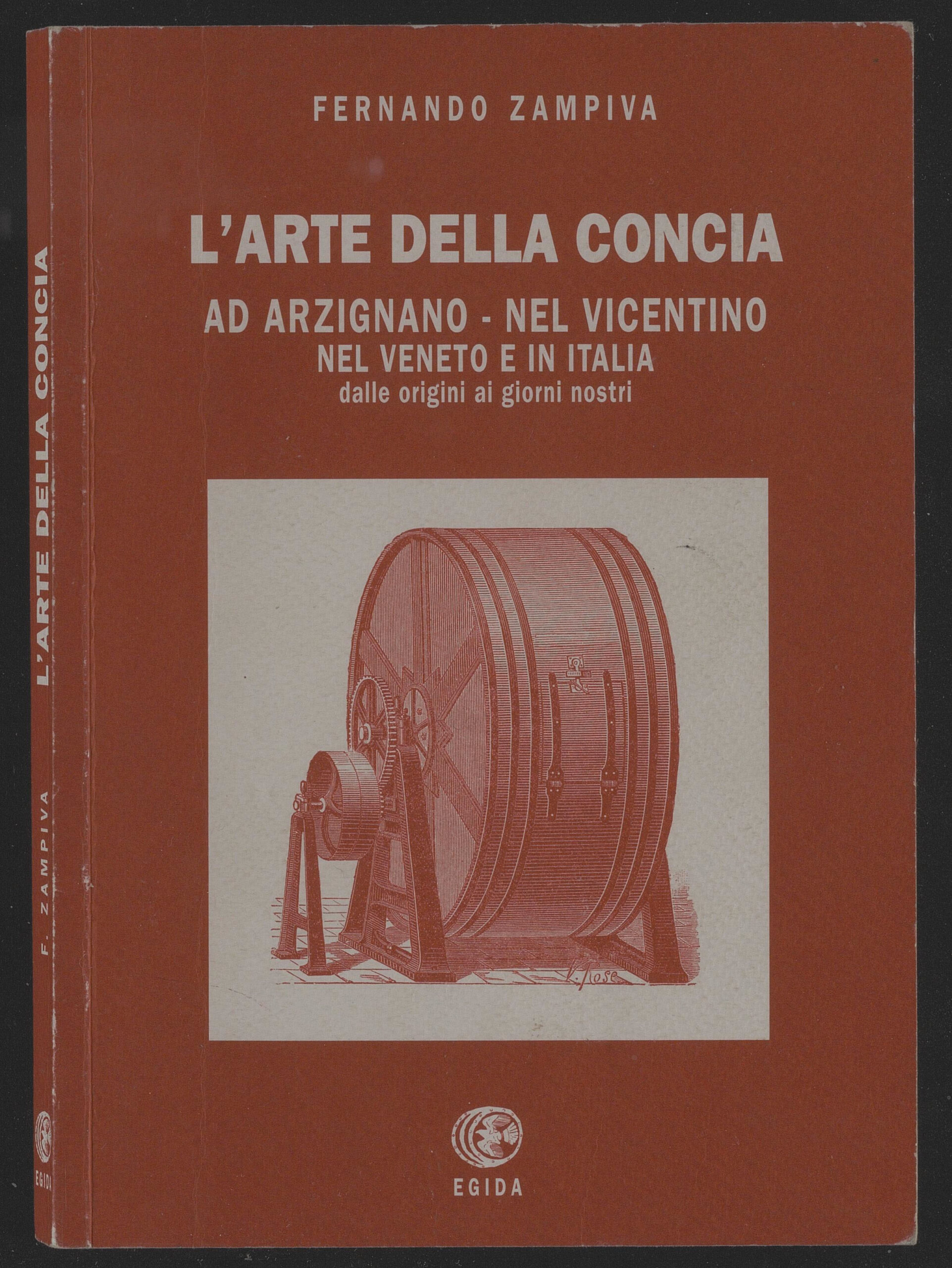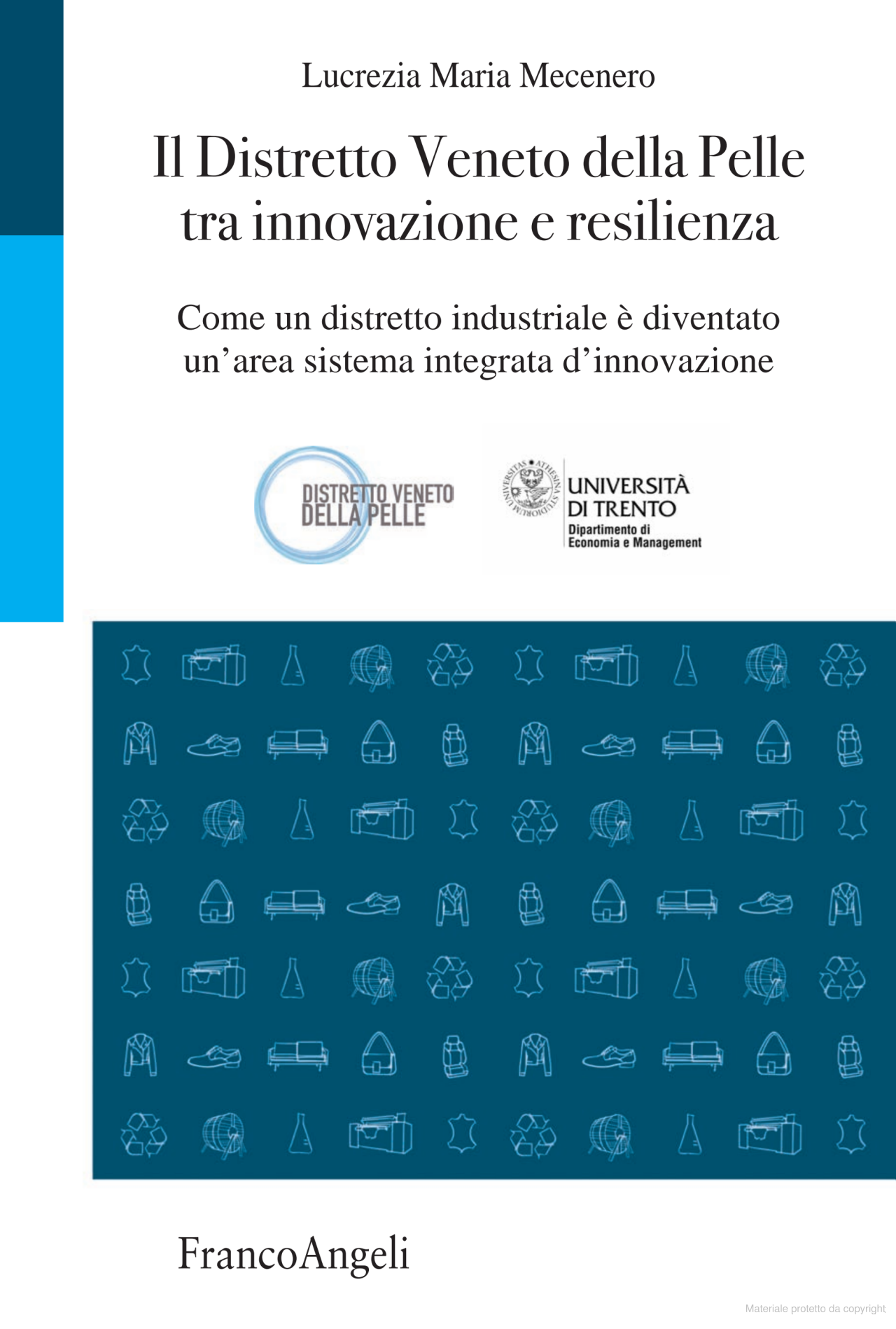Mission e STORIA
Indice:
Cos'è ARZIGNANO CAPITALE della PELLE
Capitale della Pelle® nasce con la registrazione del marchio di proprietà del Comune di Arzignano riconosciuto in data 11.01.2022 dal Ministero dello Sviluppo Economico e registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in conformità al Dlgs 10/02/2005, n. 30.
Arzignano Capitale della Pelle rappresenta una visione, un progetto multi-tematico di valorizzazione territoriale dedicato appositamente all’eccellenza produttiva conciaria e alla sua filiera strategica sviluppata nel territorio di Arzignano e della Valle del Chiampo.
Alessia Bevilacqua Sindaco di Arzignano
Enrico Marcigaglia Vicesindaco, ideatore e Presidente Comitato Arzignano Capitale della Pelle
__________________________________________________
“Abbiamo creato un marchio gestito direttamente dal Comune,
perché la concia e la pelle sono un patrimonio
e un orgoglio collettivo dell’intera comunità di Arzignano.
Un marchio dal forte impatto comunicativo,
che mostra la sicurezza del nostro passato e la nostra decisione verso il futuro.
In un pianeta sempre più globalizzato ed interconnesso,
abbiamo voluto sviluppare un progetto di Land identity e Land Marketing
che sappia raccontare chi siamo e cosa ci rende unici.
Un marchio collettivo che vuole unire le nostre aziende in un sistema di valori ed obiettivi condivisi.
Arzignano Capitale della Pelle,
un modo semplice e chiaro per presentarci al mondo.”
OBIETTIVI
• 1 – Riconoscibilità internazionale. Nel settore delle pelli, Arzignano è conosciuta nel mondo per essere il polo dell’eccellenza conciaria italiana e mondiale. La protezione del marchio opera nella direzione di creare un brand territoriale che già da decenni compete con successo nei mercati internazionali. La riconoscibilità del prodotto e della qualità italiana deve passare necessariamente attraverso l’identificazione del territorio ove è sviluppata la manifattura. Questa azione vuole inoltre essere un doveroso riconoscimento ad un settore, ad un’industria, a dei lavoratori che con il loro lavoro hanno permesso lo sviluppo della città di Arzignano che conosciamo oggi.
• 2 – Tutela del Made In Italy. Con la Legge 27 dicembre 2023, numero 206, approvata dal Parlamento, l’industria della lavorazione della Pelle è ufficialmente riconosciuta tra le filiere di prodotto di alta qualità nel sistema “Made In Italy”. Questo provvedimento mira a stimolare l’imprenditorialità di eccellenza italiana, arricchendo il nostro Made in Italy attraverso l’acquisizione di nuove risorse, competenze e tutele aggiuntive e azioni per migliorare la collaborazione tra i principali attori impegnati nella promozione e protezione dell’eccellenza italiana.
• 3 – Tutela ambientale. Tuttavia, non si può parlare di Capitale della Pelle senza un ambizioso piano di miglioramento ambientale che dia uno slancio in avanti nelle politiche per la riduzione degli impatti della produzione sul territorio. Su questa importante sfida, oggi si registra una grande positività e collaborazione tra il Comune, le Acque del Chiampo Spa (società pubblica dedicata alla depurazione civile e industriale) e il Distretto della Pelle. Pertanto, siamo certi che stiamo lavorando tutti assieme nella giusta direzione per sviluppare un’economia a ridotto impatto ambientale.
• 4 – Formazione Specialistica. Inoltre, una vera Capitale della Pelle deve avere un sistema di formazione dedicato, una sorta di ‘Università della Pelle’. Negli ultimi anni, grazie alle sinergie con il sistema scolastico, ad Arzignano è stato progettato un ciclo di studi dedicato al settore delle pelli che inizia con il diploma superiore in Tecnologie del Cuoio e Biotecnologie Ambientali, si sviluppa poi nel post diploma Green Leather Manager e arriva fino all’Università Cà Foscari di Venezia, con le borse di studio di Acque del Chiampo per il Master Universitario di Diritto dell’Ambiente.
COMITATO E REGOLAMENTO
In data 20/04/2022 con Delibera di Giunta Comunale, è stato costituito il Comitato Arzignano Capitale della Pelle, con lo scopo di redigere una proposta di Regolamento per l’Uso del Marchio che è stato approvato in data 22/12/2022 con apposita Delibera del Consiglio Comunale. L’obiettivo del “Regolamento d’Uso del Marchio” e la relativa modulistica per la richiesta di adesione, hanno l’obiettivo di rendere accessibile e gratuito l’uso del marchio “Arzignano Capitale della Pelle” alle aziende dotate dei 10 requisiti previsti dal Regolamento. Il Comitato è composto dai rappresentanti di tutte le realtà cittadine: Comune, Società di Depurazione, Scuole, Associazioni economiche e sociali del territorio.
LE AZIENDE PARTNER DI CAPITALE DELLA PELLE
Per aderire al progetto di Arzignano Capitale della Pelle ed ottenere l’attestazione d’uso del marchio, le aziende possono presentare la richiesta con relativa documentazione attestante il possesso di 10 requisiti studiati con l’obiettivo di valorizzare le aziende del territorio in termini di:
- TIPOLOGIA ATTIVITA’ (Attività Pelli o filiera strategica integrata)
- REGOLARITA’ AZIENDALE (Iscrizione alla Camera di Commercio)
- REGOLARITA’ dei LAVORATORI (Applicazione del contratto nazionale)
- UBICAZIONE GEOGRAFICA (presenza operativa nel territorio di riferimento ai 13 comuni del Bacino Valle del Chiampo)
- REGOLARITA’ FISCALE (Documento di Regolarità Fiscale DURF o Certificato Unico Debiti Tributari dell’Agenzia Entrate)
- REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (Documento di Regolarità contributiva DURC)
- SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (Congruità dell’indice infortuni aziendale ISAR INAIL)
- AMBIENTE (Certificazioni ambientali e Autorizzazioni Ambientali)
- LEGALITA’ e MORALITA’
- REGOLARITA’ delle TASSE COMUNALI
IL DISTRETTO DELLA PELLE
Oggi, il Distretto Veneto della Pelle (moderna definizione dell’ente consortile, nato nel 2009, per aggregare le realtà produttive dello storico “triangolo della pelle”, con ai vertici Arzignano, Chiampo e Montebello Vicentino) occupa un’area notevolmente più estesa, comprendendo ben 28 Comuni. Arzignano rimane tuttavia, il comune più importante, in cui si trova il 40% delle unità produttive e opera il 50% degli addetti dell’intera industria nazionale.
Il Distretto è ormai di gran lunga il primo polo italiano per l’industria conciaria, e uno dei maggiori a livello sia europeo che mondiale grazie ad una filiera della pelle che conta più di 600 aziende, 12 mila occupati e oltre 3 miliardi di fatturato, che rappresentano circa 1% del Pil prodotto dall’intero Export italiano.
La conoscenza tecnologica interdisciplinare, che permette miglioramenti continui nella produzione, si basa su competenze ed esperienze accumulate nel corso di molti decenni. L’interazione quotidiana tra gli attori produttivi locali e le industrie “ancillari” che operano a loro servizio ha dato vita a un modello imprenditoriale di successo definibile “ecosistema di innovazione“, paragonabile ad uno dei più celebri esempi in questo campo: la Silicon Valley.
ARZIGNANO
Arzignano (Vicenza) è una città di circa 26.000 abitanti situata nel cuore del Veneto, a pochi chilometri da Vicenza e Verona. La città è capofila di un’ estesa area urbana (Valle del Chiampo) che conta circa 60.000 abitanti.
ECONOMIA. Arzignano ha una forte vocazione industriale e commerciale, in particolare è conosciuta a livello internazionale per essere “Capitale della Pelle ®” grazie al primario distretto conciario della lavorazione delle pelli per la moda, l’arredamento e l’automotive. Il Tasso di occupazione (tra i 15 e 64 anni) è del 68%, +11% rispetto media italiana del 61%. Il Reddito medio è di € 26.511, +23% rispetto media italiana di € 21.570. Secondo il censimento ISTAT 2011, le aziende attive erano circa 2.200 per un totale di 12.000 addetti (impiegati al 60% nella manifattura e il 15% nel commercio).
PRESENZE GIORNALIERE. Durante le giornate lavorative, Arzignano ospita oltre 60 mila persone circolanti al giorno, un numero molto importante che di fatto più che raddoppia il numero di residenti. Il dato è calcolato matematicamente grazie ad un flusso di circa 40.000 singoli veicoli al giorno (dato telecamere targa system) moltiplicato per un tasso di occupazione medio per veicolo di circa 1,4 persone/auto e sommato ad un 20% di mobilità leggera (pedoni e biciclette).
VIABILITA’. Un altro punto di forza di Arzignano è la sua posizione strategica e ben collegata con le principali infrastrutture viarie della regione grazie al nuovissimo casello autostradale sulla nuova Autostrada Pedemontana Veneta, nel punto di innesto con la A4 Milano-Venezia. Nel complesso Arzignano dispone di rete viaria locale di oltre 220 km.
SICUREZZA. L’ Indice medio degli ultimi 5 anni, relativo alla Lesività degli incidenti stradali (nonostante le persone circolanti siano il doppio delle residenti) è di circa 128, circa -5% rispetto alla media nazionale di 135. L’ Indice di delittuosità (reati ogni 100.000 abitanti) è 885 pari a circa il -75% rispetto alla media nazionale di 3.500 . In particolare, il perimetro cittadino e i principali assi viari sono coperti da un avanzato sistema di circa 50 telecamere intelligenti (targa system), che garantiscono oltre 200 mila controlli targa al giorno.
NATALITA’. Grazie alla numerose attività industriali presenti in città, Arzignano da decenni offre svariate possibilità di lavoro anche a cittadini provenienti da altre regioni e paesi, favorendo un’intenso scambio culturale e solide opportunità di vita per costruire la propria famiglia. L’età media è di 44 anni, -5% rispetto alla media italiana di 46 anni (-5%). Il Tasso di natalità (per mille abitanti) è del 8,8, +31% rispetto alla media italiana del 6,7. L’Indice di vecchiaia è del 154%, -16% rispetto alla media italiana del 183%.
Il Tasso di Popolazione Internazionale è del 17%, +100% rispetto media italiana del 8,5%
IL GEMELLAGGIO CON SAMOS, l'antica città della concia
Nel 2022 è stato approvato all’unanimità del consiglio comunale di Arzignano la creazione del primo gemellaggio della storia della Città del grifo. Arzignano CAPITALE DELLA PELLE e l’Isola di Samos, Karlovasi (Grecia) ANTICA CITTA’ DELLA CONCIA nel Mediterraneo, sono accomunate da un medesimo spirito imprenditoriale, e rappresentano assieme la storia e il presente di questa nobile e antica arte della lavorazione della pelle.
Samos Kalovasi, in Grecia, è stata Capitale della Concia fino al 1912. Il momento d’oro dell’arte conciaria dell’isola corrisponde ad un periodo compreso tra il 1880 e il 1930. All’epoca nella sola municipalità di Karlovasi vi erano cinquanta concerie, che davano lavoro a oltre 300 persone. Ad oggi esiste a Karlovasi un Museo della Concia che permette non solo di conoscere questo mestiere e la sua storia. Samos inoltre è famosa nella storia per aver dato i natali a Pitagora, Epicuro ed Aristarco.
PUBBLICAZIONI SULLA STORIA DELLA CONCIA
600 ANNI DI STORIA DELL’INDUSTRIA CONCIARIA DI ARZIGNANO

Estratto dal Libro “Il Distretto Veneto della Pelle tra innovazione e resilienza”, 6 ottobre 2021, di Lucrezia Maria Mecenero
La pelle nella storia di Arzignano
La produzione di manufatti in pelle accompagna la storia dell’uomo dalle origini. Già gli uomini preistorici conciavano le pelli che indossavano utilizzando grassi animali. Alcune tecniche tradizionali di lavorazione sono rimaste invariate lungo i millenni e hanno segnato lo sviluppo dell’artigianato conciario.
Per la concia delle pelli si utilizzavano l’allume (esistente in natura sotto forma di minerale, la kalinite) e altre sostanze vegetali a base, tra gli altri, di corteccia di quercia, pino e salice o di crosta di melograno.
Sicuramente, la grande disponibilità di acqua contribuì a rendere Arzignano, come altri paesi lungo la valle del fiume Chiampo, un luogo particolarmente adatto ad accogliere le concerie fin dalla notte dei tempi. Le prime testimonianze scritte della presenza di pelliparii (un termine vago che nel Medioevo indicava coloro che «si procuravano, preparavano e vendevano» pelli) risalgono ad alcuni registri notarili del 1400.
Da queste annotazioni, si deduce che il commercio di pelli tra Arzignano e Venezia doveva essere molto prospero e vivace. Sempre dai registri locali si scopre che, nel 1465, esisteva già, in località Riotorto, una grande industria conciaria. Concerie grandi e piccole sorsero nella zona per utilizzare per le loro lavorazioni la forza dell’acqua del Chiampo, trasportata da numerosi canali di irrigazione.
Nel 1490, gli Statuti ed Ordeni del Comune et Huomini d’Arzignano conteneva le norme sull’utilizzo dell’acqua e la sua difesa, elaborate principalmente per evitare l’inquinamento, e le sanzioni pecuniarie per chi non le rispettava. Altri documenti dello stesso periodo stabilirono che solo di sabato fosse possibile prelevare acqua dai canali per provvedere all’irrigazione di prati e campi, oppure vietarono l’immersione delle pelli in punti specifici dei corsi d’acqua.
La concia, da artigianato a industria
Per tutto il 1800, in generale, le concerie faticarono a passare dalla dimensione di piccola bottega artigiana a quella industriale, risentendo sempre più della concorrenza dei produttori di altre parti d’Italia ed esteri, che utilizzavano tecniche più avanzate, comprendenti l’uso di nuovi estratti conciari, sali di cromo e macchinari innovativi.
La trasformazione industriale della zona, infatti, fu guidata, come in molte altre parti d’Italia, non dall’industria conciaria, bensì da quella della seta. Alla metà del secolo, lungo la valle del Chiampo si contavano circa 180 filande, in cui lavoravano più di mille persone.
L’artigianato conciario iniziò a trasformarsi in industria solo tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900. I primi segnali di innovazione si possono scorgere a partire dal 1892, quando, nell’intera provincia di Vicenza, furono censite 6 concerie in possesso di motori meccanici, di cui una proprio ad Arzignano. Possedeva un motore idraulico con la potenza di 7 cavalli e impiegava 30 lavoratori.
La Brusarosco di Arzignano fu una delle aziende che contribuirono a diffondere il progresso tecnico nella zona, basandosi sull’utilizzo della chimica. Altre concerie industriali furono la Lumen di Giuseppe Meneghini, portata dai figli ad affermarsi anche all’estero, e la Cazzanello, fondata dal ventenne Antonio Cazzanello, la prima in zona a occuparsi della concia di pelli in pelo, come quelle di capre, agnelli, conigli e volpi.
La Prima guerra mondiale, grazie alle commesse dell’esercito, diede una spinta notevole ai ritmi dell’innovazione tecnica del settore. Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’industria della concia, nel periodo tra le due guerre mondiali, lo svolse però la crisi di quella della seta che, come detto, rappresentava l’industria trainante della zona. Nel 1927-28, secondo una rilevazione della Camera di commercio di Vicenza, il distretto di Arzignano era al primo posto in zona per numero di filande. La crisi del settore, decretata dalla scoperta della seta artificiale (nylon) e dalla forte concorrenza della seta giapponese, generò una grande disponibilità di manodopera, già formata e abituata al lavoro in fabbrica.
Alla decadenza dell’industria della seta fecero da contraltare le industrie conciarie che occuparono, anche fisicamente, i luoghi delle ex-fabbriche tessili e assorbirono gli operai in esubero. Furono introdotte macchine sempre più moderne, che sfruttarono il vapore e l’elettricità e, verso il 1930, anche la concia al cromo.
Il secondo dopo-guerra e il boom del settore
Il vero boom arrivò negli anni della ricostruzione post-bellica. Fu in quel periodo che molti lavoratori delle “concerie storiche” della zona si misero in proprio e iniziarono ad aprire le loro fabbriche. Fino a tutti gli anni Sessanta, grazie ai bassi investimenti di capitale necessari per aprire una nuova azienda, si gettarono le basi per lo sviluppo di un sistema produttivo diffuso, di cui facevano parte realtà grandi e piccole e che comprendeva attori operanti in tutti i settori della filiera produttiva. Una dinamica che fu alla base della nascita, anche in molte altre realtà italiane, di quelli che oggi chiamiamo i “Distretti industriali”.
Tra il 1951 e il 1961, il numero di imprese della concia crebbe, nella sola Arzignano, del 366%. Lo sviluppo tumultuoso del settore spinse a investire anche nella formazione. Nel 1962, venne fondato l’Istituto tecnico industriale per la chimica conciaria Galileo Galilei. Si trattò della seconda scuola di questo tipo aperta in Italia, dopo Torino, e attrasse studenti provenienti anche da altre parti d’Italia.
Dall’inizio degli anni Settanta, Arzignano rappresentò un polo di attrazione per chiunque fosse alla ricerca di un impiego nell’industria. Nel solo anno 1971, furono circa 470 le persone che vi si trasferirono. Molti altri occupati nel settore conciario, negli stessi anni, andarono a vivere nei comuni vicini (come Chiampo o San Pietro Mussolino) per la maggiore disponibilità di alloggi e il loro minor costo.
Ad Arzignano, che scontava al tempo la presenza nel centro storico di molte concerie, l’amministrazione locale ordinò la costruzione di un impianto di trattamento delle acque all’avanguardia e il decentramento delle fabbriche dal centro cittadino, anche se questo processo fu completato solo negli anni Ottanta.
Lo sviluppo dei settori della chimica e delle macchine per concia
Negli stessi anni in cui il settore iniziò, lungo tutta la valle del Chiampo, a trasformarsi in un vero e proprio “Distretto industriale” con Arzignano al proprio centro, si assistette allo sviluppo di altre industrie, cosiddette “satelliti” o “ancillari”. Il primo gruppo di industrie apparteneva al settore meccanico e si occupava della produzione dei macchinari utilizzati nella concia, all’inizio al servizio delle sole concerie del distretto. La seconda, importante industria “ancillare” fu quella chimica, specializzata nei processi conciari.
Le prime macchine per la concia venivano dalla Germania e furono acquistate di seconda mano negli anni Cinquanta. Piccole officine della zona, attive come riparatori o rivenditori, si trasformarono ben presto in produttori e, grazie agli stretti contatti con le industrie che quei macchinari utilizzavano, li modificarono e migliorarono. Aziende fondate ad Arzignano, come la Fratelli Poletto (1955) e la 3P (1966), riuscirono in breve tempo ad affermarsi sul mercato grazie ai progressi tecnologici apportati ai macchinari.
Dalla Germania iniziò anche la storia delle industrie chimiche. Qui avevano sede, negli anni Cinquanta, quasi tutte le multinazionali che lavoravano nel settore della concia (Bayer, BASF, Hoechst). Molte di loro, negli anni Sessanta, aprirono filiali nel distretto di Arzignano. A queste aperture fecero seguito quelle di industrie locali, come la Samia S.p.A. (1976).
Le filiali furono spesso aperte a scopi puramente commerciali, in quanto lo spostamento di produzioni chimiche presenta molte complessità e difficoltà. Tuttavia, nel corso del tempo, molte di queste filiali commerciali divennero laboratori di ricerca e sviluppo, strategici per sfruttare al meglio le sinergie con i produttori locali e testare sul posto i nuovi prodotti richiesti dalle industrie del Distretto.
La “delocalizzazione inversa” e la “conoscenza tacita”
Il boom del Distretto conciario continuò lungo tutti gli anni Ottanta, proseguendo nel percorso di crescita comune alla quasi totalità dei distretti industriali italiani, con un grande successo dei suoi prodotti sul mercato internazionale e un deciso aumento dei flussi di esportazione.
Una particolarità del Distretto conciario, rilevabile dalla fine degli anni Ottanta in opposizione a una dinamica ricorrente in altri settori e realtà territoriali, è l’assenza di un processo di delocalizzazione industriale. Nonostante la grande disponibilità di manodopera a basso salario garantita dal trasferimento dei processi di produzione in paesi in via di sviluppo, il Distretto scelse di continuare la produzione di alta qualità in loco. Trasferì all’estero, al massimo, le prime fasi del processo produttivo, con l’ottenimento di prodotti semilavorati in quei paesi, come il Brasile, in cui la materia prima (le pelli grezze) abbondava.
La decisione “strategica” di non delocalizzare le fasi a più alto valore aggiunto della produzione fu influenzata da alcuni fattori, tra i quali il fenomeno della “conoscenza tacita” fu di fondamentale importanza. La “conoscenza tacita” è data dall’insieme delle competenze professionali e delle pratiche operative trasmissibili solo attraverso l’esperienza diretta. Si tratta di competenze estremamente difficili da codificare per consentirne un apprendimento a distanza. Vi erano, poi, le “ricette aziendali”, più o meno segrete, per le operazioni di riconcia e tintura. I lavoratori in possesso di questi fondamentali know-how erano restii a trasferirsi all’estero e, vista la difficoltà di una sistematica codificazione in regole scritte e immutabili dei saperi acquisiti con l’esperienza, l’intero processo di delocalizzazione avrebbe rischiato di portare a una cattiva gestione dei processi produttivi.
La mancata delocalizzazione, all’inizio degli anni Novanta, mise a rischio la sopravvivenza del Distretto stesso, vista la cronica difficoltà di reperire operai in zona. Ci si rivolse sempre all’estero, cercando di attrarre quelle risorse umane, non qualificate, necessarie allo svolgimento dei compiti per i quali era difficile trovare manodopera locale disponibile.
Il Distretto Veneto della Pelle oggi
Oggi, il Distretto Veneto della Pelle (moderna definizione dell’ente consortile, nato nel 2009, per aggregare le realtà produttive dello storico “triangolo della pelle”, con ai vertici Arzignano, Chiampo e Montebello Vicentino) occupa un’area notevolmente più estesa, comprendendo ben 28 Comuni. Arzignano rimane tuttavia, il comune più importante, in cui si trova il 38% delle unità produttive e opera il 49% degli addetti.
Il Distretto è ormai di gran lunga il primo polo italiano per l’industria conciaria, e uno dei maggiori a livello sia europeo che mondiale. Nella zona, la filiera pelle conta più di 600 aziende, 11 mila occupati e oltre 3 miliardi di fatturato. Uno dei suoi segreti è la capacità di adattarsi alle mutate esigenze del mercato, per esempio spostando buona parte della sua produzione nel settore automobilistico, in precedenza considerato un business collaterale.
La qualità della produzione continua a rappresentare una delle principali fonti di vantaggio competitivo del Distretto Veneto della Pelle, non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche quantitativo. La conoscenza tecnologica, che assicura i continui miglioramenti delle produzioni, si basa su tutte le “competenze tacite” e le esperienze accumulate negli anni e sull’interazione giornaliera tra gli attori produttivi presenti sul territorio e le industrie “ancillari” che operano al loro servizio. Questo stretto interscambio ha dato origine a un promettente modello imprenditoriale: quello di un moderno “ecosistema di innovazione”, assimilabile a uno dei più rinomati e importanti esempi in questo campo: la Silicon Valley.
Lucrezia Maria Mecenero ha raccontato la storia da cui prendono spunto e origine le notizie riportate in queste pagine in un saggio esaustivo e completo, ricco di dati e considerazioni, dal titolo Il Distretto Veneto della Pelle tra innovazione e resilienza, edito da Franco Angeli. La pubblicazione della ricerca è stata sostenuta dal Distretto, che ha attivamente contribuito alla sua realizzazione, in quanto si è posto, da qualche tempo, l’obiettivo di collaborare con studiosi e ricercatori interessati a comprendere i fenomeni del nostro territorio e del nostro tempo.